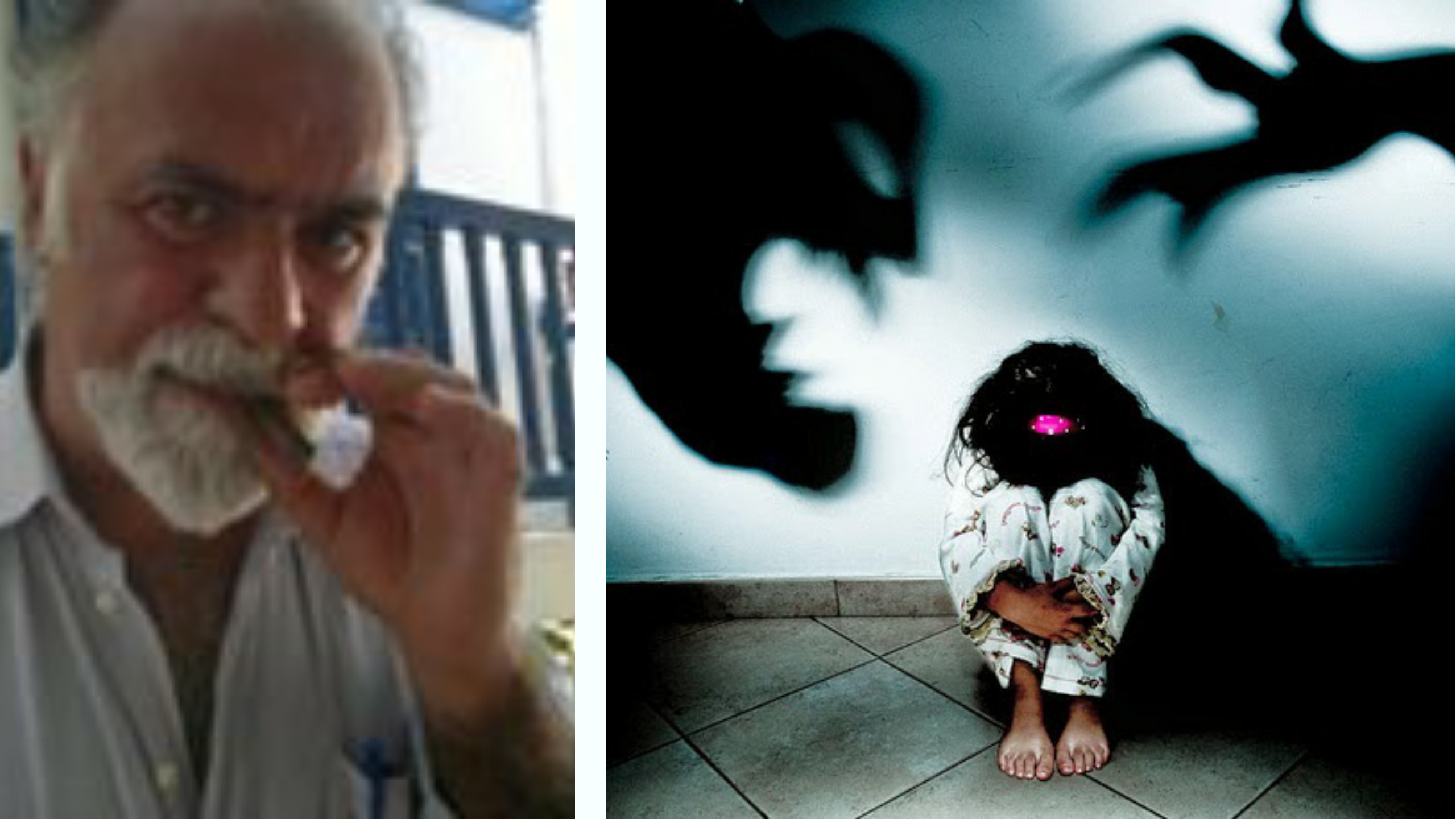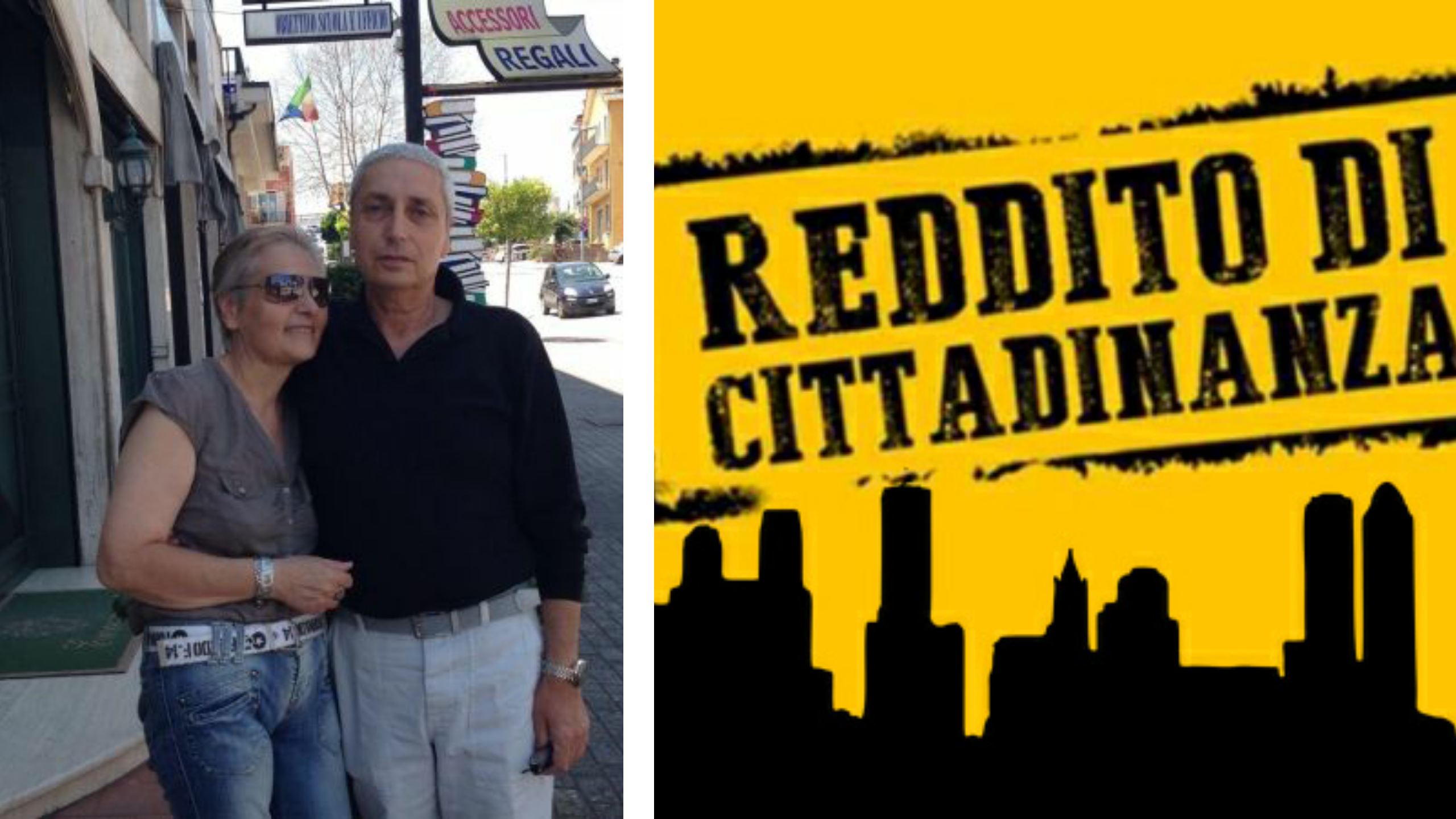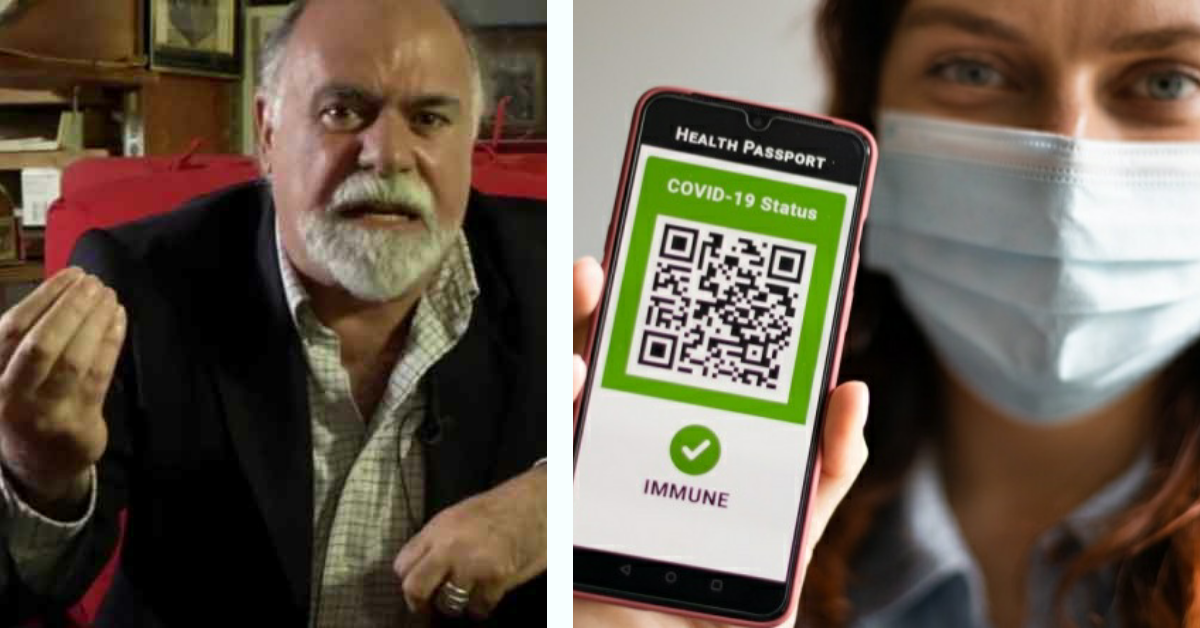Il rischio è che queste decisioni trasformino il continente in un mercato di guerra permanente, alimentato da una narrativa di paura e minaccia costante.
L’Unione Europea ha lanciato il piano “ReArm Europe”, un’iniziativa senza precedenti che mira a rafforzare le capacità di difesa del continente con un budget stimato fino a 800 miliardi di euro. L’iniziativa, sostenuta da 26 dei 27 Stati membri, è stata presentata come una risposta alla crescente minaccia rappresentata dalla Russia. Tuttavia, questa corsa agli armamenti solleva interrogativi fondamentali: l’Europa ha davvero bisogno di un riarmo così massiccio o sta semplicemente alimentando un’ulteriore escalation militare?
La narrativa della minaccia russa
Dopo il conflitto in Ucraina, i governi europei hanno giustificato il riarmo con la necessità di contrastare un’ipotetica espansione russa verso l’Europa occidentale. Questa prospettiva ha portato alla creazione di una “coalizione dei volenterosi”, composta da Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, con l’adesione di altri paesi come Italia, Spagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia, Canada, Australia, Giappone e Corea del Sud.
Se da un lato la difesa è un diritto sovrano di ogni nazione, dall’altro è lecito chiedersi se esista davvero un pericolo immediato di invasione russa dell’Europa occidentale. Ad oggi, non esistono prove concrete che la Russia abbia intenzione di attaccare Berlino, Parigi o Roma. La guerra in Ucraina è stata condotta nel contesto di una lunga disputa territoriale e di sicurezza con la NATO, ma equiparare questo conflitto a una minaccia diretta all’intera Europa è una forzatura geopolitica.
Un elemento chiave di “ReArm Europe” è il forte coinvolgimento di nazioni extraeuropee, come Canada, Australia e Giappone, che difficilmente possono essere considerate parte di una strategia difensiva puramente europea. La presenza di questi attori solleva il dubbio che il piano di riarmo sia più allineato agli interessi della NATO e degli Stati Uniti che a quelli dell’Unione Europea.
La politica di difesa dell’UE, infatti, sembra sempre più vincolata agli interessi strategici di Washington, che da anni spinge per un aumento delle spese militari europee. La domanda è quindi inevitabile: ReArm Europe serve a proteggere i cittadini europei o a rafforzare un blocco militare filo-occidentale in chiave anti-russa?
L’unico paese dell’UE che si è rifiutato di aderire al piano è l’Ungheria di Viktor Orbán, che ha espresso forti perplessità sull’aumento delle spese militari e sul rischio di escalation. Budapest ha più volte ribadito la necessità di un approccio diplomatico con Mosca, opponendosi all’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina.
Questa posizione, però, è stata duramente criticata da Bruxelles, che ha accusato l’Ungheria di essere troppo vicina alla Russia. Tuttavia, si potrebbe anche interpretare la scelta ungherese come un tentativo di non farsi trascinare in una spirale di militarizzazione senza ritorno.
Una spesa militare fuori controllo
Il riarmo europeo non è solo una questione strategica, ma anche economica. 800 miliardi di euro rappresentano una somma enorme, che avrebbe potuto essere destinata a priorità più urgenti, come:
– La transizione energetica e l’indipendenza dalle risorse fossili;
– Il rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali;
– La lotta alle disuguaglianze sociali e alla crisi economica post-pandemia.
Invece, l’Europa ha scelto di potenziare la sua industria bellica, a beneficio di aziende produttrici di armi come Rheinmetall (Germania), Dassault (Francia) e Leonardo (Italia). Il rischio è che queste decisioni trasformino il continente in un mercato di guerra permanente, alimentato da una narrativa di paura e minaccia costante.
Gli inquietanti parallelismi con la vigilia della Prima Guerra Mondiale
Il piano “ReArm Europe” presenta spaventosi parallelismi con la corsa agli armamenti che precedette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Anche allora, l’Europa viveva un periodo di apparente pace e prosperità, mentre sotto la superficie le potenze continentali alimentavano una spirale di militarizzazione che avrebbe portato alla catastrofe.
Come nel periodo 1905-1914, assistiamo oggi a una drammatica accelerazione nella spesa militare che rischia di creare una “profezia che si autoavvera”. Prima del 1914, ogni nazione si armava citando la necessità di difendersi dalle altre potenze che, a loro volta, aumentavano il proprio arsenale proprio in risposta a queste minacce percepite.
Oggi, il riarmo occidentale viene giustificato con la minaccia russa, mentre la Russia risponde aumentando il proprio potenziale militare di fronte all’espansione della NATO. È il classico “dilemma della sicurezza”: misure intraprese per aumentare la propria sicurezza finiscono per diminuire quella complessiva, alimentando un circolo vizioso.
Le alleanze militari come fattori di instabilità
Prima della Grande Guerra, l’Europa era divisa in due blocchi rigidamente contrapposti: la Triplice Alleanza (Germania, Austria-Ungheria, Italia) e la Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia, Russia). Questo sistema di alleanze, concepito per garantire la sicurezza, si trasformò nel meccanismo che amplificò un conflitto locale in una guerra mondiale.
Oggi, la NATO si è espansa fino ai confini della Russia, mentre Mosca rafforza le proprie alleanze con Cina, Iran e altre potenze regionali. Come nel 1914, un sistema di patti militari automatici rischia di trasformare qualsiasi incidente locale in un conflitto globale, sottraendo ai diplomatici il tempo e lo spazio necessari per la mediazione.
La corsa agli armamenti pre-1914 trasformò profondamente le economie e le società europee, orientandole verso la produzione bellica e normalizzando un discorso pubblico basato sullo scontro inevitabile. Il famoso “Piano Schlieffen” tedesco, ad esempio, era basato sull’idea che la guerra fosse non solo possibile, ma probabile e persino necessaria.
Il piano “ReArm Europe”, con il suo enorme budget e l’obiettivo di creare una “economia di guerra”, rischia di produrre lo stesso effetto: dirottare risorse critiche verso la produzione militare, rendere accettabile l’idea di un conflitto imminente e creare interessi economici che hanno tutto da guadagnare da un clima di tensione permanente.
L’illusione del controllo
Forse il parallelismo più inquietante è l’illusione che i leader politici possano mantenere il controllo su questa dinamica. Nel luglio 1914, i governanti europei credevano di poter gestire la crisi scatenata dall’attentato di Sarajevo, sottovalutando la velocità con cui gli eventi avrebbero preso una direzione propria.
Oggi, con armi ipersoniche, guerre informatiche e potenziali “incidenti” nello spazio cibernetico o nei teatri di guerra periferici, il rischio di perdere il controllo è esponenzialmente maggiore. I tempi di reazione si sono drasticamente ridotti, e la possibilità che un errore di calcolo o un malinteso porti a un’escalation incontrollabile è concreta.
Se l’obiettivo è davvero garantire la sicurezza del continente, la strada del riarmo non è necessariamente la migliore. Una politica basata sulla diplomazia, il dialogo e la riduzione delle tensioni internazionali potrebbe essere più efficace nel lungo periodo rispetto a una corsa agli armamenti che rischia di portare solo più instabilità e conflitti.
Il pericolo di un’invasione russa dell’Europa resta, per ora, una speculazione. Tuttavia, quello che è già reale è il progressivo allineamento dell’UE agli interessi della NATO e degli Stati Uniti, con un impatto significativo sulla politica estera e sulle risorse economiche europee.
La domanda che i cittadini europei dovrebbero porsi è semplice: chi sta davvero guadagnando da questo riarmo? E soprattutto: non stiamo forse ripercorrendo, con tragica ironia, gli stessi passi che un secolo fa portarono l’Europa all’abisso?
Come ci insegna la storia, il vero pericolo non è tanto la guerra dichiarata, quanto la spirale di misure e contromisure che, passo dopo passo, la rendono inevitabile. Cento anni dopo lo scoppio della Grande Guerra, dovremmo aver imparato che armarsi fino ai denti in nome della pace è la più pericolosa delle contraddizioni. Solo che questa volta, le conseguenze potrebbero essere infinitamente più catastrofiche.
Stefano Becciolini